Lezioni della cultura Zen
ô
-
Le lezioni della cultura Zen
-
Non puûý sorprendere che l'aspirazione religiosa, la mentalitû del credente, le speculazioni filosofiche dell'europeo colto abbiano, oggi, tra i loro poli d'attrazione, i simboli dell'Oriente, cosû˜ come un tempo accadeva che i cuori e le menti degli uomini fossero attirati da idee cristiane.
Karl Gustav lung, Archetipi dell'inconscio collettivo -
Ognuna delle principali forme culturali Zen û´ intesa ad agire sulla mente in forme condizionanti, sû˜, ma non di tipo occidentale. A ben guardare, si costata che nessuna delle tipologie Zen ha un effettivo contraltare nella cultura dell'Ovest. Il tiro all'arco e l'arte della spada sembrano poco meno che una sorta di ipnotismo; i giardini Zen sono una serie di trucchi specificamente intesi a sviare la percezione; la pittura Zen û´ un prodotto dell'antimente non razionale, sebbene richieda un addestramento altrettanto rigoroso di quello assicurato da qualsiasi accademia occidentale (ma, nel momento critico, l'insegnamento viene dimenticato, l'opera si fa del tutto spontanea). Il teatro Nûý si serve di abili espedienti suggestivi per condurre la mente in sfere della comprensione troppo profonde per essere espresse a parole, mentre lo haiku "aperto" û´ una scintilla che provoca un'esplosione di immagini e percezioni non razionali nella mente del lettore-ascoltatore. La casa giapponese tradizionale û´, dal pavimento al tetto, un aggregato psicologico.
-
La ceramica Zen, con i suoi sottili inganni, liquida le nostre aspirazioni alla categorizzazione, obbligandoci a sperimentare direttamente materiali, processi, forme. La cerimonia del tû´ costituisce un altro tentativo di alterare deliberatamente lo stato mentale, questa volta sotto la maschera di una semplice occasione sociale. Si direbbe quasi che le arti Zen siano state intese come una lezione oggettuale circa le limitazioni dei sensi ai fini della definizione della realtû . Esattamente come il kû°an mette a dura prova la mente logica, le arti Zen, giocando con la perfezione, ci rammentano esservi una realtû impermeabile ai cinque sensi. Secondo la filosofia orientale, sebbene "vedere" coinvolga i sensi, in ultima analisi deve trascenderli. ãÂ
-
La cultura Zen û´ stata elaborata nel corso dei secoli per metterci in contatto con una parte di noi che, in Occidente, conosciamo appena, cioû´ il nostro risvolto non razionale, non verbale, laddove i maestri Ch'an giû mille anni fa elaboravano esercizi mentali destinati a sconfiggere, mettendolo per cosû˜ dire in corto circuito, il risvolto razionale con le sue limitazioni. Si ricordi che l'idea dell'antimente solo in tempi recenti ha avuto convalide sperimentali, e quindi rispettabilitû intellettuale, nell'Occidente razionalista. Per fare un solo esempio: da recenti esperimenti compiuti alla Harvard University, û´ risultato che ô¨ domande che richiedono... processi verbali..., hanno per effetto la massima attivazione dell'emisfero cerebrale sinistro... mentre situazioni emozionali provocano la massima attivazione dell'emisfero destro ô£.'
-
Si direbbe che i maestri Ch'an, non solo si siano intuitivamente resi conto dell'esistenza della metû non verbale della mente giû durante l'era T'ang (618-907), ma che, come piû¿ tardi i giapponesi, se ne siano serviti per dar vita a una gamma di modalitû artistiche e culturali che sfruttano, rafforzano ed esaltano queste stesse facoltû non verbali. Le manifestazioni culturali Zen costituiscono la perfetta, concreta riprova dei poteri dell'antimente. Persino quelle che del linguaggio si servono (Nûý e haiku), si basano piû¿ sulla suggestione che sulle parole. E anzi, la stessa lingua dell'arcipelago û´ stata di recente descritta, da uno studioso giapponese, in termini tali da farla a sua volta sembrare poco meno che un fenomeno intuitivo, antimentale: ô¨ L'inglese û´ una lingua intesa rigorosamente alla comunicazione.
-
Il giapponese, invece, si interessa soprattutto allo stato d'animo dell'altro, onde stabilire la condotta da tenere sulla scorta di impressioni ô£. Questa differenza di atteggiamento nei confronti della lingua, tale per cui essa û´ vista quale una virtuale barriera che impedisce di trasmettere ciûý che û´ davvero significante (vale a dire la propria risposta soggettiva), sembrerebbe un effetto collaterale della cultura Zen. Per dirla con un moderno critico giapponese:
Un corollario dell'atteggiamento giapponese verso il linguaggio potrebbe essere definito Inestetica del silenzio": la reticenza assurge a virtû¿ e la verbalizzazione o l'aperta espressione dei propri pensieri intimi appare un atto di volgaritû . -
Tale atteggiamento puûý essere ricondotto all'idea buddhista Zen, essere l'uomo capace di approdare al piû¿ alto livello della contemplativitû soltanto allorchûˋ non compia tentativi di verbalizzazione e consideri l'espressione orale il massimo della superficialitû . Infine, le forme culturali Zen si servono dei poteri non verbali, non razionali, della mente, per indurre nel fruitore un senso totale di identificazione con l'oggetto. Un'opera d'arte puûý considerarsi davvero riuscita allorchûˋ lo spettatore non abbia il senso dellã"io" e dell' "esso". Qualora si richiedano riflessione o analisi, l'opera non vale piû¿ di una barzelletta che richieda una spiegazione. La mente dello spettatore deve immediatamente esperire qualcosa che trascende l'opera. Come l'occhio non puûý vedere se stesso senza uno specchio, cosû˜ accade con la mente. Provocare l'introspezione diventa una deliberata funzione dell'arte Zen, consistente nell'obbligare la mente ad andare al di lû della forma superficiale dell'opera, incontro all'esperienza diretta di una realtû piû¿ alta.
-
E ci si rende allora finalmente conto che le arti Zen sono in tutto e per tutto introiettate. Esse dipendono dalla percezione dello spettatore o fruitore tanto quanto dalle lord implicite qualitû . Proprio per questo possono e debbono" essere parsimoniose e contenute, e accade anche che siano perfettamente adatte a un paese che, per secoli, û´ stato caratterizzato da una grande penuria materiale. Sviluppandosi su piccola scala, codeste arti basate sulla suggestione dipendono in larga misura, quanto a impatto, sulla particolare percezione dell'uditorio, e cosû˜ gli artisti Zen sono stati in grado di procurare immensa soddisfazione con il ricorso a risorse limitate: qualcosa di simile al rapporto tra radiodramma e spettacolo televisivo.
-
Dato un uditorio dotato di buona immaginazione, l'autore di un radiodramma, al pari di un artista Zen, potrû ottenere l'effetto desiderato mediante suggestione. û ciûý cui pensava Sir George Sansoni, richiamando l'attenzione sul ruolo importante svolto dal sentimento estetico nell'arricchimento della vita nipponica. Nei giapponesi di tutte le classi sociali, una spontanea coscienza della bellezza sembra costituire il compenso per un livello di vita che, secondo i criteri occidentali, appare povero e tetro. L'abitudine dei giapponesi di trovare soddisfazione nelle cose d'ogni giorno, il loro pronto apprezzamento della forma e del colore, la loro sensibilitû per la semplice eleganza, sono doni che ben meritano di essere invidiati da noi che tanto dipendiamo, per la nostra felicitû , dalla quantitû delle cose possedute e dalla complessitû di apparecchiature. Queste felici condizioni, tali per cui la frugalitû non û´ nemica della soddisfazione, costituiscono forse le caratteristiche piû¿ salienti del divenire culturale del Giappone.
-
La cultura Zen, che giû usufruiva di un vocabolario e di una capacitû di percezione elaboratissimi, quali erano andati sviluppandosi in era Heian, ha saputo elaborare nuove, efficacissime tecniche che hanno fatto, della cultura nipponica tutta quanta, un caso a sûˋ negli annali della civiltû mondiale. Forse l'esempio piû¿ efficace ne û´ costituito dal giardino di pietre di Ryûýan-ji, trionfo della pura suggestivitû . Esso û´ chiaramente un simbolo -ô ma un simbolo di che cosa?
-
û un invito a rendere piû¿ aperta la propria percezione - ma aperta a che cosa? L'opera non fornisce alcuna indicazione. Con il Ryû°an-ji, gli artisti Zen hanno portato l'espediente della suggestione a un punto tale, che essa potû´ vivere di vita propria. Il giardino sembra quasi un oggetto naturale, simile a un tramonto o a un pezzo di legno trasportato dalle correnti. Non diverso û´ l'effetto che produce una tradizionale stanza Zen, la quale semplicemente amplifica la capacitû di comprensione di cui giû dispone lo spettatore; in sûˋ e per sûˋ, essa û´ un vuoto. -
Basandosi a tal punto sulla suggestione, i giapponesi hanno elaborato una maniera straordinariamente originale di servirsi dell'arte e di sperimentarla. Per centinaia d'anni, i critici occidentali hanno dibattuto sulla funzione dell'arte, sulle responsabilitû degli spettatori di fronte all'opera, sui vari livelli di perfezione, e via dicendo, ma mai si sono occupati del fenomeno peculiare all'arte Zen, per cui l'opera puûý essere un semplice mezzo per mettere in moto la mente. E del resto, come si potrebbe scrivere un'analisi critica di un'opera che prende forma solo una volta che û´ stata registrata dal fruitore? û interessante vedere i critici alle prese con il Ryû°an-ji, tesi nel tentativo di spiegarne la pregnanza, solo per ritirarsi, alla fine, sconfitti. Allo stesso modo, i piû¿ efficaci haiku sono quelli a proposito dei quali meno û´ possibile dire.
-
Chi vede per la prima volta il Ryûýan-ji, resta letteralmente senza fiato: come uno haiku ben coniato, esso impone allo spettatore un attimo di esperienza diretta. Ma, quando ci si prova ad analizzarlo, si costata che non c'û´ niente di significativo da dire in merito. Puûý darsi persino che il Ryûýan-ji non sia un'opera d'arte secondo la definizione occidentale, ma una sorta di espediente mentale per il quale non ci sono equivalenti verbali. Cosû˜, il rapporto tra haiku e poesia occidentale puûý darsi che si limiti agli aspetti tipografici. Le arti dell'Occidente - pittura, poesia, drammaturgia, letteratura, scultura - sono tutte sorrette dall'analisi critica. In effetti noi Milton lo leggiamo attraverso molti strati di spiegazioni e interpretazioni critiche. Le arti Zen non hanno ispirato un simile corpus di analisi critiche, probabilmente perchûˋ mancano di molte di quelle qualitû alle quali di solito diamo il nome di estetiche. Forse che il Ryûýan-ji û´ dotato di bellezza nella nostra accezione convenzionale? Esso semplicemente esiste. Semmai, lo si potrebbe definire antiarte.
-
Se in Occidente vogliamo attingere al mondo complesso della cultura Zen, dobbiamo innanzitutto addestrare e intensificare i nostri poteri percettivi. E da questo punto di vista, si û´ tentati di affermare che i giapponesi hanno imparato, questi poteri, a esaltarli da un lato ma a reprimerli dall'altro. Come altrimenti spiegarsi la loro cecitû per le devastazioni della civiltû moderna, mentre in pari tempo continuano a coltivare una sorta di feticismo nazionale per un fenomeno puramente estetico come i fiori di ciliegio?
-
Come ha detto Donald Richie, ô¨ il Giappone û´ il piû¿ moderno di tutti i paesi forse perchûˋ, disponendo di un passato ricco e sicuro, puûý permettersi di vivere nel presente istantaneo ô£. L'antico senso del gusto sembra essere sopravvissuto, senza subire danni, accanto a tutti gli orrori estetici del XX secolo; l'interesse per la bellezza continua a costituire una parte assai importante della vita d'ogni giorno in Giappone e, mentre nei nostri paesi l'apprezzamento dell'arte û´ di solito monopolio di una limitatissima minoranza di privilegiati, in Giappone le qualitû estetiche degli oggetti d'uso quotidiano sono generalmente riconosciute come altrettanto importanti della loro funzione pratica. Non û´ inconsueto vedere un rozzo manovale intento a disporre fiori, a praticare la cerimonia del tû´, a costruirsi un giardino durante il tempo libero. Il contadino puûý essere giudice altrettanto abile, in fatto di ciotole da tû´, di un principe. Persino le scatole di fiammiferi dei piû¿ infimi bar sono piccole opere d'arte, al pari delle confezioni dei pacchi anche dei piû¿ moderni grandi magazzini. Il senso della bellezza non û´ considerato effeminato, ma anzi û´ ritenuto essenziale alla buona vita, e si rifû ai virili samurai.
-
La lezione prima della pittura Zen û´ che dovremmo cominciare a sforzarci di sperimentare l'arte e il mondo attorno a noi, anzichûˋ analizzarli. E, facendolo, costateremmo come ogni cosa all'improvviso acquisti vita. Se riusciamo a far nostra questa capacitû di percezione diretta e a integrarla, rafforzandola con gli espedienti dell'arte Zen, nelle attivitû di ogni giorno, scopriremo, in oggetti comuni, una bellezza che prima ignoravamo. I fiori, addirittura singoli petali, appariranno dotati di straordinaria grazia. In chi veda il mondo con una consapevolezza resa piû¿ acuta dallo Zen, l'interesse per la bellezza degli oggetti soppianterû il desiderio di possederli; e, se permetteremo agli antichi creatori di cultura Zen di sfiorare le nostre esistenze, apriremo un po' di piû¿ le porte della percezione.
ô

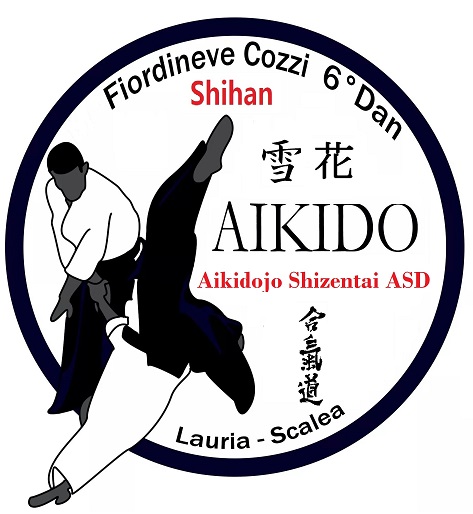
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.JPG) ô ô
ô ô 

.jpg)

.jpg)





.jpg)
.JPG)