SpiritualitĂ del Giappone
SPIRITUALITĂ€ DEL GIAPPONE
IL BUSHIDO
-
Per fare un discorso coerente ed attendibile sul Bushido, sarebbe necessario inquadrare il fenomeno dei Bushi o Samurai in un contesto storico, culturale e sociale che dovrebbe abbracciare un lungo periodo a partire dal 1000 d.C. circa, sino quasi all'epoca Tokugawa, ossia, ai primi contatti con le culture occidentali. Una simile trattazione ci porterebbe, comunque, molto lontani da ciò che intendiamo esprimere in questo nostro saggio che si prefigge di penetrare, al di là dei fatti storici, più in profondità , nel tentativo di scoprire le ragioni e le modalità che hanno fatto sì che l'epopea dei Samurai si perpetuasse nel tempo sino ai giorni nostri e che il Bushido fosse una via valida, attraverso la quale, al guerriero giapponese era dato di raggiungere quelle mete spirituali che sono proprie soltanto alle grandi religioni della terra.
E' innegabile, comunque, che il giapponese è un popolo bellicoso, un popolo di guerrieri la cui storia è costellata di guerre di ogni portata nelle quali rifulge il valore degli eserciti e dei loro comandanti, l'organizzazione tattica in battaglia ed il potenziale di armamento, ma sopra ogni altro
fattore si distingue, nel combattimento a breve distanza, nel corpo a corpo, la figura del singolo: il valore puro del Samurai. Dobbiamo tenere conto, infatti, che in combattimenti all'arma bianca è sempre il valore del singolo che viene chiamato in causa e che anche una battaglia di vaste proporzioni si riduce in definitiva a scontri fra uomo e uomo. Se è vero che tatticamente uomini come Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Yeyasu, furono comandanti di grande acume e capacità , è pure innegabile che, almeno per quanto riguarda Oda, egli scese in campo con soli 2.000 uomini contro un esercito di ben 25.000, guidato da Yamagawa Yoshimoto, distruggendolo e volgendo in fuga i superstiti che, inseguiti, persero pure il loro Capo. Possiamo arguire che una simile clamorosa vittoria sia stata il frutto di tempismo, sorpresa, tattica, e tutto ciò che può venire in mente ma è innegabile che il grande esercito avversario fu sconfitto dal valore puro dei Samurai guidati da Oda Nobunaga.
Questo non è l'unico esempio che la storia cì fornisce sulle grandi doti guerriere dei Samurai.
Sorge dunque la domanda: quali ragioni, quali condizioni hanno fatto sì che dei combattenti fossero a tal punto superiori ad altri? Certo, l'uso costante delle armi, il loro diuturno contatto, la loro perfetta padronanza dovuta all'allenamento, come diremmo noi oggi, ma oltre a questo, cosa faceva del Samurai un Samurai e degli altri che tali non erano, semplice massa d'urto, carne da cannone, per usare un termine in uso qualche decennio addietro? Abbiamo detto che il popolo giapponese è un popolo bellicoso ma questa bellicosità si è col tempo, col trascorrere dei secoli, imbevuta di religione e di misticismo. La religione ha portato il suo contributo che solo raramente, comunque, è riuscito a mitigare lo spirito marziale nipponico e che, incredibilmente, ha invece alimentato un modo nuovo di vedere la guerra, una nuova maniera di affrontare il combattimento e la morte, al di là degli interessi personali, della sete di gloria (che muoveva, ad esempio, i pur valorosi soldati della Roma imperiale), e dell'orgoglio. Tutto sommato, questa simbiosi di religione quietistica e pacifista quale, principalmente il Buddhismo e di guerra, non dovrebbero sorprenderci eccessivamente, dal momento che il Medio Evo cristiano vide il dilagare di guerre sante, combattute in nome di Cristo: di quello stesso Cristo che aveva predicato la pace e l'amore, che aveva chiesto ai suoi seguaci di « essere pacifici come una colomba » e di « porgere l'altra guancia ». Ma per tornare a noi, come possiamo immaginare una conciliazione fra l'idea della guerra e l'amore universale ed i principi di misericordia peculiari del Buddhismo? Quali punti di contatto possiamo addurre fra i principi di amore della Natura, di conformità alle leggi dell'Universo, ispirati dallo Shinto e dal Taoismo, fra quelli di ordine sociale ed etico dettati dal Confucianesimo, e la guerra che è sempre, in ogni caso, l'esatto opposto di tutto ciò, fonte di caos, di disordine sociale, di odio, di dolore e di distruzione? La religione indica all'uomo mete elevate di spiritualità , di ricerca, di amore, concordia, fraternità fra i popoli. In pratica, il Buddhismo il cui anelito è tutto volto alla ricerca di una via per l'estinzione della catena delle rinascite, via che passa, per l'appunto, attraverso gli ideali teste enunciati, ha dato un volto definitivo al Bushido, alla « Via del guerriero” , con la sua dottrina di salvazione attraverso uno sforzo personale, un rovesciamento dello stato umano per il conseguimento della conoscenza interiore della verità e quindi alla liberazione. E se il Buddhismo aveva introdotto la dottrina della liberazione, il Taoismo che lo aveva imbevuto nel lungo soggiorno cinese, prima dell'introduzione nell'Arcipelago, aveva aggiunto il suo notevole contributo, in particolare nella formulazione di quella branca buddhistica che, per la sua immediatezza di espressione, lo Zen, aveva fatto maggiormente presa sulla classe dei guerrieri. I concetti di etica confuciana e lo spirito nazionalistico e teocratico dello Shinto, avevano fatto il resto. La guerra era sempre stata un male necessario ed i guerrieri, di conseguenza, erano sempre esistiti; ora, tuttavia, essi trovavano una loro giustificazione morale al punto da elevare a via di salvazione la loro via. Nel tentativo di sintetizzare i principi che muovono il Bushido, potremmo dire che, se combattere è inevitabile (in quanto a ciò troviamo una eco di battaglia in noi stessi, nell'assolvimento dei nostri compiti giornalieri, anche i più imbelli), e se possiamo in qualche modo salvarci, dobbiamo trovare la via di salvezza proprio nella guerra. L'amore di Patria, terra degli dei della Nazione, l'amore del Sovrano, Dio vivente in terra, del Popolo, anch'esso di discendenza divina, il disprezzo della morte, dovuto anche alla certezza che essa non è che un aspetto della vita, transitorio e di ordine personale, non qualcosa di definitivo ma piuttosto un episodio in un più vasto contesto, hanno fatto della figura del Samurai giapponese, qualcosa di raramente riscontrabile nella storia dell'umanità . Il Boenio-Brocchieri, nel suo saggio « Note su una storia dello Zen »,si esprime così: Resta un ultimo tema, quello della simbiosi, a prima vista assurda ed incredibile, tra la dottrina quietista, anarchica, anti mondana dello Zen e la bellicosa classe dei Samurai. La spiegazione a grandi linee stà proprio nello sdoppiamento all'interno dello Zen, di dottrina e disciplina psicologica. Entro certi limiti la seconda è utilizzabile anche a prescindere dalla prima. Ciò che attraeva i Samurai non era tanto la rinuncia al mondo, l'ideale bucolico del « vivere nascostamente », che attraeva Chomei. Era il perfetto controllo di sé che il magistero Zen imponeva ai suoi adepti; applicato agli uomini di guerra, questo controllo si traduceva in sprezzo per il pericolo, in capacità di astrarre da quanto non fosse il preciso compito imposto a ciascuno, in assoluta devozione al Signore feudale attraverso la instaurazione di un rapporto che duplicava in sede pratico-politica, quello esistente fra maestro ed allievo ». Nel Bushido, come nella Cavalleria medioevale d'occidente della più nobile tradizione, l'azione guerresca non deve mai indulgere ad inutile crudeltà , semmai, al contrario, deve essere nobile e disinteressata, perché, come dice il Tucci nel suo « Bushido » : « Il popolo giapponese è guerriero, non rapace”. Il concetto della vita nel Bushido è strettamente aderente alle leggi fondamentali della Natura. Stagionalmente la Natura si rinnova, risorge dopo la morte apparente dall'inverno imposta. Così è per l'uomo in generale e per il Samurai in particolare che è come un delicato fiore di ciliegio i cui petali, nel breve volgere di pochi giorni si distaccano e cadono. La vita deve, per quanto possibile anche interiormente, rifarsi a queste eterne leggi, senza mai forzarle a proprio vantaggio, seguendo l'anelito stesso della Natura verso la perfezione di Dio, attraverso la ricerca della perfezione spirituale e fisica. Così il mistico la cercherà nell'ascesi, l'uomo comune nell'assolvimento dei propri doveri, senza eccessi passionali, con la mente libera e calma, ed il guerriero cercherà la propria perfezione nell'arte sua preparandosi per tutta la vita ad incontrare vittoriosamente la morte. Vittoriosamente non perché egli la potrà evitare con l'abilità od altro ma perché la morte che è l'umano spauracchio davanti al quale ogni cuore vacilla, per il Samurai è soltanto, un aspetto, sia pure negativo, della vita, che va affrontato a cuore aperto; qualcosa dinanzi a cui non si trema, non si implora, non si striscia, ma che si riceve come il supremo crisma dell'eroismo e che, se è necessario, ci si impone da se stessi.E' interessante il racconto che nel dramma Nó di Zeami, « Sanemori », il fantasma di questi, un vecchio Samurai, ne fa al monaco viandante che lo incontra nei pressi del campo di battaglia ove morì. Sanemori, per i suoi capelli bianchi, non incontrava in guerra avversari degni di lui che accettassero la sua sfida. Prevedendo la disfatta del suo Signore, Taira no Munemori, ad opera del clan Minamoto, e deciso a morire combattendo, si tinse capelli e barba di nero, vestendo sotto la corazza gli abiti più sgargianti ed affrontando così un giovane guerriero che ben presto lo uccise. Ma Zeami, da buon buddhista, non si ritiene pago dell'azione di Sanemori, che, tutto sommato, anche se lodato dai suoi stessi avversari, è pur sempre un'azione fraudolenta e fa vagare il suo spirito sul campo di battaglia in cerca di chi, vivo, possa, con la preghiera, liberarlo dalla sua condanna.
Il Bushido, come via di salvazione, impone, dunque, una vita da asceta, in cui non vi è posto che per la rettitudine senza condizione e l'onore, ove passioni ed eccessi sono superati dalla fermezza d'animo ed il coraggio di vivere, da quello di morire con onore. Questi principi sono gli stessi che informano per una ovvia traslazione, tutte le arti marziali giapponesi, principi, che tuttavia, non rappresentano il vero segreto del Budo, quel segreto che si palesa soltanto da una intuizione interiore che prescinde dal ragionamento, dalla logica, dalla deduzione, quel segreto che il Maestro Ueshiba ha cercato per tutta la sua giovinezza e che, scopertolo, ha divulgato al mondo attraverso il suo Aikido. Se questo mondo è un mondo in conflitto, noi possiamo, tuttavia, attraversarlo a testa alta, senza esserne contaminati né turbati, con coraggio vivendo e con coraggio affrontando la morte, se siamo capaci di cogliere il significato recondito del Bushido ed attraverso la forza interiore che da esso ci viene, superare e trascendere ogni conflitto.

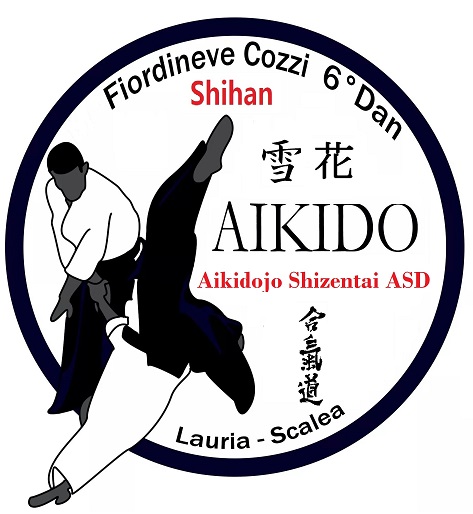
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.JPG) Â Â
  

.jpg)

.jpg)





.jpg)
.JPG)